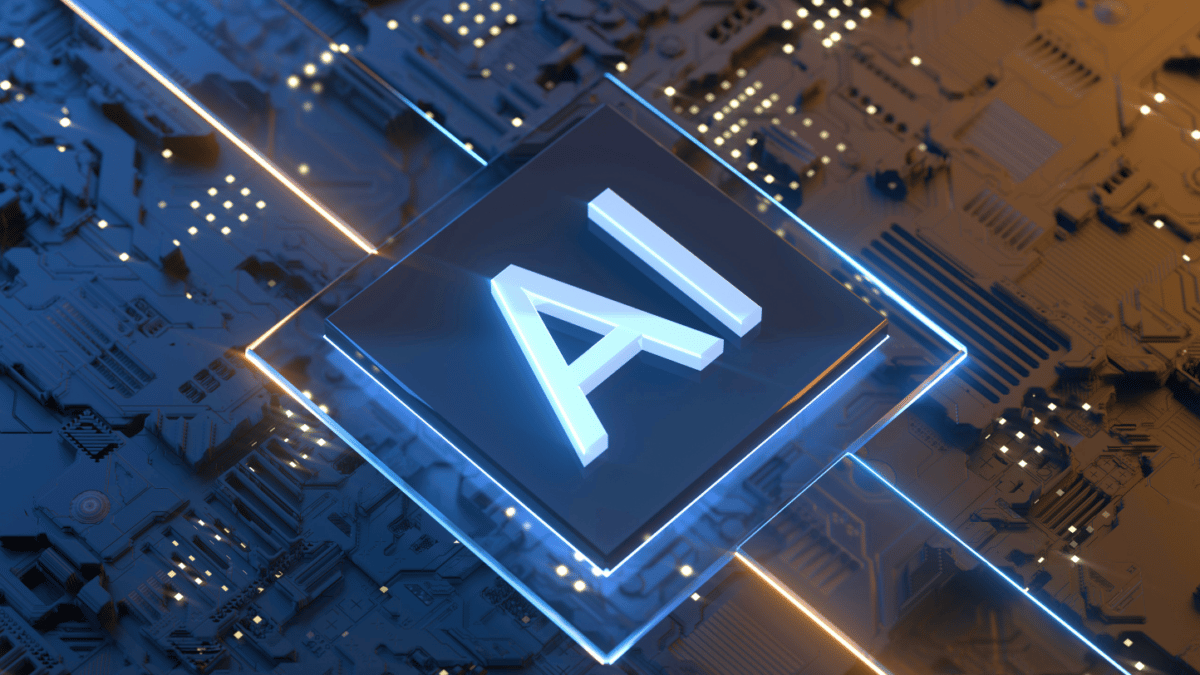di Ludovico Conti
Viviamo in un’era sempre più mediatizzata. Quelli tradizionali come la televisione sono affiancati dai social media e dalle piattaforme. Ma questa pervasività dei media quale impattato ha su di noi? Come è cambiato il nostro rapporto con i media dopo la spettacolarizzazione del dolore, come ad esempio quello a cui siamo esposti da tre anni a questa parte con il Covid prima e la guerra poi?
Ne parliamo con il professor Massimiliano Coviello, docente associato di cinema e televisione presso la Link Campus University di Roma.
L’immagine dei media è sempre più pervasiva, soprattutto quando parliamo di spettacolarizzazione del dolore. Nel suo saggio “Le temporalità delle immagini della guerra al terrore” già si rifletteva sull’impatto che le immagini dell’11 settembre avevano sull’opinione pubblica. Erano gli anni 2000, oggi la situazione mediale è differente ed è aumentata l’esposizione a questa tipologia di immagini?
Alcune cose sono cambiate, non possiamo non analizzare il panorama mediatico, il dialogo tra i media, forme e formati. Non solo l’uso dei social media, ma anche le pratiche di visione ed i contenuti di alcuni prodotti visivi come film e serie televisive. Come affermano in molti, l’11 settembre è l’evento mediatico di questo millennio. Un altro grande evento che è prossimo a noi e che inevitabilmente ci ha segnato è quello della pandemia. La pandemia ha prodotto fenomeni nuovi sia a livello di pratiche che di contenuti e formati. Dopo la pandemia cosa è successo?
Abbiamo cambiato le abitudini: la nostra dieta mediatica, i nostri consumi di contenuti audiovisivi e di produzione di contenuti audiovisivi è cambiata ed è aumentata. Ma dobbiamo capire come questo aumento ha impattato sulle pratiche quotidiane, sulle azioni collettive e quelle pratiche legate allo stare insieme. Sicuramente un antropologo direbbe che “scacciamo il male”, in maniera apotropaica, noi ci rifugiamo nei riti collettivi nelle festività e questo accadeva anche prima della pandemia inevitabilmente per sentirci ancora insieme.
Come si è giunti a mettere quasi sullo stesso piano le immagini virtuali e la vita reale?
Il cambiamento è un’accelerazione: l’11 settembre ci ha spostato in un mondo dematerializzato, la pandemia ci ha abituato ancora di più a frequentare uno spazio nuovo. In questo senso mi viene in aiuto un concetto di un professore di Filosofia ed Etica dell’Università di Oxford, Luciano Floridi, il quale conia il concetto di Onlife e lo fa poco prima della pandemia.
Cosa vuol dire Onlife e perché riflettere sull’importanza di questo concetto?
Oggi non c’è più distinzione tra pratiche digitali/virtuali e reali: noi siamo continuamente connessi e quello che facciamo su uno schermo si ripercuote nella nostra quotidianità materiale. Questo concetto è, oggi, altamente rilevante, come si può osservare dal rapporto sulla comunicazione del Censis di fine dicembre, “I media delle crisi”, studio effettuato tra il 2021 e 2022 e che pone molta attenzione sui temi caldi della pandemia e del conflitto russo-ucraino. In questo rapporto vi sono due concetti interessanti: Era Biomediatica e Primato dello sharing sulla privacy. Il primo riguarda “il primato dell’io-utente, produttore esso stesso oltre che fruitore di contenuti della comunicazione”.
Noi creiamo contenuti, siamo inglobati nelle grandi aziende che ne sono broadcaster (da Netflix a Facebook, Tiktok ecc). Chi li produce e li distribuisce è consapevole di quale è la voglia, la capacità e l’interesse degli utenti all’interno di questo mondo biomediatico; in contrapposizione gli utenti stessi sono diventati più capaci di saper stare nel flusso comunicativo, con strumenti tecnici migliori, più semplici, più immediati e più potenti. L’altro elemento è quello del primato dello sharing sulla privacy: non solo produciamo contenuti personali ma vogliamo condividerli. Un “broadcast yourself” (trasmetti té stesso), come dice anche il popolare slogan di Youtube. Sono modi per stare assieme, ma allo stesso tempo vuol dire che creaiamo e cediamo dati. Oramai ne stiamo diventando sempre più consapevoli di quest’aspetto, siamo disposti a cedere informazioni, ad essere tracciati perché questo ci permette di condividere. Le pratiche dello stare assieme sono diventate anche pratiche di promozione e visibilità.
In questa “Era biomediatica” come dialogano, in televisione, le immagini della guerra in Ucraina, dei terremoti in Turchia con l’iperstimolazione dei contenuti di intrattenimento che si trovano nelle piattaforme di streaming o nei social media?
Possiamo dire che anche la guerra in Ucraina e il terremoto in Turchia, benché fenomeni diversi, vengono riscritti dalle pratiche biomediatiche dei social. Cosa voglio dire: la guerra in Ucraina viene riscritta per icone nei social media. Un esempio? In un fascio di luce che viene proiettato su un palazzo Kiev compare la scritta 100k, dove il numero rispecchia la somma dei soldati russi uccisi. Veramente ci esaltiamo di fronte alla distruzione ed uccisione di 100 mila soldati morti e lo promuoviamo come se fossero i fasci luminosi con cui addobbiamo i palazzi, i monumenti storici durante le festività?
In parte è questo, ma è anche vero che questo modo di fare serve a sminuire il nemico, perché in guerra c’è anche questo. Se da un lato la Russia costruisce il suo modello comunicativo per giustificare la sua azione bellica, la sua invasione, attraverso la censura e propaganda che oscura, con Zelensky e il suo staff, dall’altro lato, c’è un gioco di pratiche di riscrittura degli avvenimenti, di mash-up di stili e non solo di contenuti che il web ci ha insegnato. È dissacrante.
Questa spettacolarizzazione, dunque, ci estetizza ed anestetizza al tempo stesso all’orrore?
Si estetizza anestetizzando, ma si utilizzano i media ed i formati per quello che sono. La guerra è sempre stata anche guerra di immagini e pratiche, di comunicazione e quindi per farla oggi bisogna stare anche in un certo modo sui canali comunicativi.
Questo, probabilmente, ci abitua ad un’altra sensibilità, come anche l’emotività che non è più quella di prima. Era già avvenuto per altri eventi come l’11 settembre. Guardando quelle immagini veniamo abituati a sviluppare una sensibilità nuova.
Questa nuova sensibilità nell’”Era biomediatica” corrisponde anche a nuove forme dell’ agire?
Per il 9/11, la televisione censurava i jumpers che cadevano e si uccidevano consapevoli che sarebbero andati incotro a morte certa; li ci trovavamo di fronte la ripetizione dell’identico. Il ripetersi dell’immagine ed il ritorno dell’immagine. Ora c’è la variazione dell’identico e questa variazione la generano anche le persone comuni, quelle la cui vita sta in un sistema che ancora dobbiamo imparare a capire fino in fondo e che non è più soltanto materiale/reale o digitale/virtuale.
Non è più qualcosa che arriva, che tu vedi, ti distacchi, ma che ti anestetitizza con la ripetizione. Con l’onlife, la distanza viene meno, noi non fruiamo più solamente mettendoci a distanza con un televisore. Ora diventiamo prosumer, siamo producer e consumer del contenuto. Cerchiamo di produrre ed ottenere l’attenzione nelle forme brevi (come ad esempio può anche essere un meme che interpreta un evento, una notizia, un fatto). Oggi l’utente comunica, è partecipe, esprime emotività attraverso la forma breve come può essere un Reel o un TikTok, ma è pur sempre un linguaggio con tempi ridotti, spontaneo, autoprodotto, bottom-up.
Da un lato vediamo che la spettacolarizzazione in televisione anche di eventi drammatici come l’entrare in terapia intensiva durante il Covid o le immagini di guerra in televisione non sempre producono una sensibilizzazione sull’argomento. Dall’altro lato abbiamo questo essere in tanti produttori di contenuti che crea un sovraccarico informativo, di contenuti e la cosiddetta infodemia. Come ci orientiamo?
Il Censis dice che pur guardando tanta televisione non ci fidiamo più; guardare tanto un medium non vuol dire riporre in esso fiducia. Vuol dire che in qualche modo gli italiani hanno capito che dietro un mezzo di comunicazione ci sono strategie che non per forza rispettano veridicità contenuti. Qui sorge un problema, perché i media tradizionali avevano anche la funzione di agenti mediatori, di educazione e formazione. Adesso abbiamo uno scrolling continuo. La questione è quindi come fare per discernere le notizie e selezionarle nel modo corretto.
Ora è più importante stare nel flusso, non ottenere un’ informazione attendibile. Stando nel flusso, si raggiunge l’obiettivo, perché i contenuti che vengono canalizzati dall’utente, rimontati e riscritti funzionano. Oggi non c’è più una reale educazione della comprensione contenuti, alla priorità delle informazioni, alla veridicità e verifica dei contenuti.
Il fatto che siamo onlife non vuol dire che non dobbiamo essere cittadini responsabili. Essere cittadini vuol dire appartenere a delle comunità, le regole dello stare insieme dovrebbero valere sia fuori che dentro rete. Queste regole contavano anche prima della rete e dovrebbero avere valenza ora ancora di più, con la rete che convive con il mondo. Bisogna porre sicuramente maggiore attenzione sul tema. Stiamo imparando ad usare i media, stiamo imparando a creare contenuti, impariamo anche che questi contenuti in modo tale da rispettare le normative.