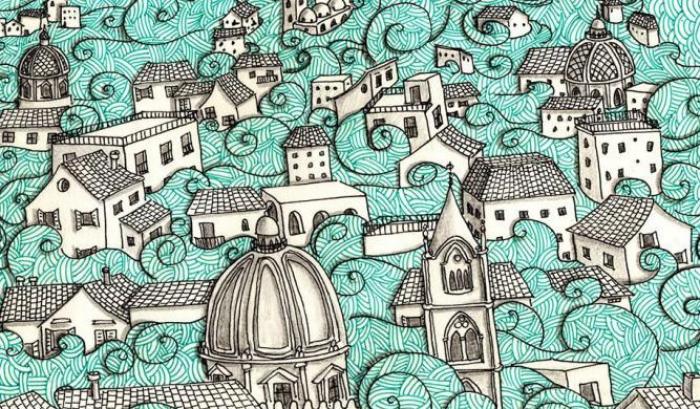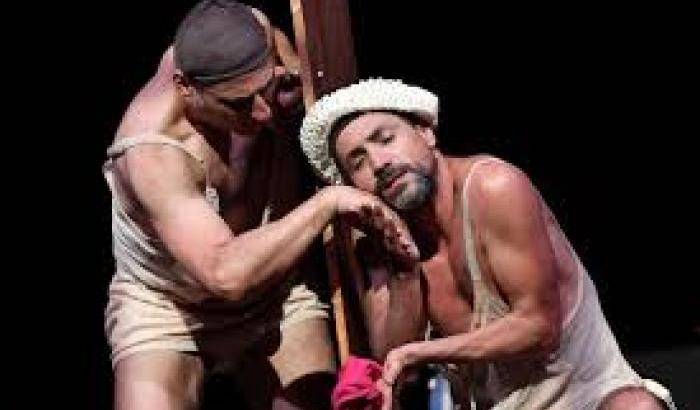di Delia Vaccarello
I galli sono uccelli, lo sapevate? Se vivono liberamente si posano sugli alberi. Volano, hanno un istinto materno fortissimo, conoscono sempre l’ora, ti scelgono se gli vai a genio. Prima di finire in un piatto, invece, non si può dire che vivano, piuttosto viene negata loro qualunque dimensione che possa definirsi vitale. E i maiali? Stessa storia. I suini hanno una emotività vicinissima a quella di noi animali umani. Sono capaci di lealtà, compassione, romanticismo, e soffrono per il lutto.
E poi, scusate ma perché per stimarli dobbiamo tracciare somiglianze? Gli animali non umani possono essere per noi l’ignoto. Lo sostiene Jeffrey Moussaieff Masson, autore de “Il maiale che cantava alla luna” (Ed. Il Saggiatore) e non solo lui, ma a un certo punto lo dice proprio bene. “A chiunque viva a stretto contatto con un’altra specie capita a volte di accorgersi che un certo animale si sta allontanando per entrare in un regno al quale non abbiamo accesso. Assume uno sguardo assente, oppure si illumina di una specie di contentezza”. Ecco, l’animale, un certo animale, è in un luogo interiore a noi sconosciuto e prova emozioni segrete a chi osserva.
Jeffrey Masson è uno psicanalista che ha deciso di dedicarsi alla vita emotiva degli animali autore del best seller “Quando gli elefanti piangono”. Proseguendo nelle sue indagini si è chiesto: cosa provano gli animali da fattoria, quelli che in genere vengono mangiati senza che ci si chieda se siano o meno “soggetti di vita”? L’idea è che siano per noi, per il nostro stomaco. Perché? E con quali conseguenze etiche l’animale umano ha sostenuto per secoli la sua superiorità e organizzato grazie alla tecnologia veri lager per animali “da carne”? (Un documentario scaricabile dal web tratto dal libro mostra i tratti salienti della ricerca).
Un esempio? Pulcini destinati a vivere un mese, ammassati in gabbie fetide, con la luce sempre accesa. Masson riesce a visitare un capannone di polli destinati al macello, impresa difficilissima perché nessuno dei nazi-allevatori ama essere raccontato. Cosa vede? “venticinquemila polli candidi,
stipati uno a ridosso dell’altro a perdita d’occhio. Era come una stanza degli specchi: polli all’infinito, tutti della stessa taglia, allineati uno dopo l’altro, che mangiavano e bevevano alla luce artificiale, in un silenzio quasi completo”. Basta un niente per farli terrorizzare, si presume vivano in uno stato costante di angoscia. “Che cosa provavano quei polli? Be’, prima di tutto una grande paura…. Disperazione? Un senso di inutilità? La speranza che le cose sarebbero
migliorate? So come mi sono sentito io, in perfetto accordo con mio figlio Ilan che mi accompagnava: Portami fuori, ti prego, mi sento male”. Il contrasto tra gli animali-merce e il loro modo di vivere se protetti nei rifugi è stupefacente. Gli animali allevati vengono torturati. Ma troppo spesso molti animali umani vogliono negare la loro sofferenza, la ignorano, e se qualcuno glielo ricorda rispondono “non mi rovinare il pasto”. Si chiama specismo. A puntare il dito contro per fondare una etica egualitaria è stato il filosofo australiano Peter Singer nel suo “Liberazione animale” (Il Saggiatore), un’opera pilastro edita per la prima volta nel 1975 e riveduta varie volte, annotando il procedere delle sevizie o le tracce di un cambiamento possibile.
Liberazione: vuol dire che ciascuna specie deve poter vivere secondo la vocazione naturale, vuol dire che noi dobbiamo garantire alcune libertà base. Tutti gli animali sono uguali, dice Peter Singer. E come cambia il nostro concetto di forza se riteniamo forte chi protegge il debole anziché torturarlo e metterlo in tavola? Come cambia la nostra idea di potenza o la nostra capacità di godere delle meraviglie degli esseri viventi? Ecco una breve storia inseribile in una possibile raccolta di vite da maiale: in un rifugio per animali sottratti alle sevizie, una scrofa zoppa e anziana viene protetta da un giovane maiale, i due sono sempre insieme e lui si sincera che lei mangi e abbia ciò che le occorre. Quando lei muore, dopo pochi giorni va via anche lui per un attacco di cuore. Conclude Masson: “È ora di guardare ai maiali non come ad animali da mettere in tavola, ma come a una famiglia lontana cui siamo legati da un’affinità profonda e speciale: stanno solo aspettando il segnale che siamo finalmente pronti a vivere con loro considerandoli esseri pari a noi per svelarci con esuberanza suina l’intera gamma della loro complessa personalità emotiva”.