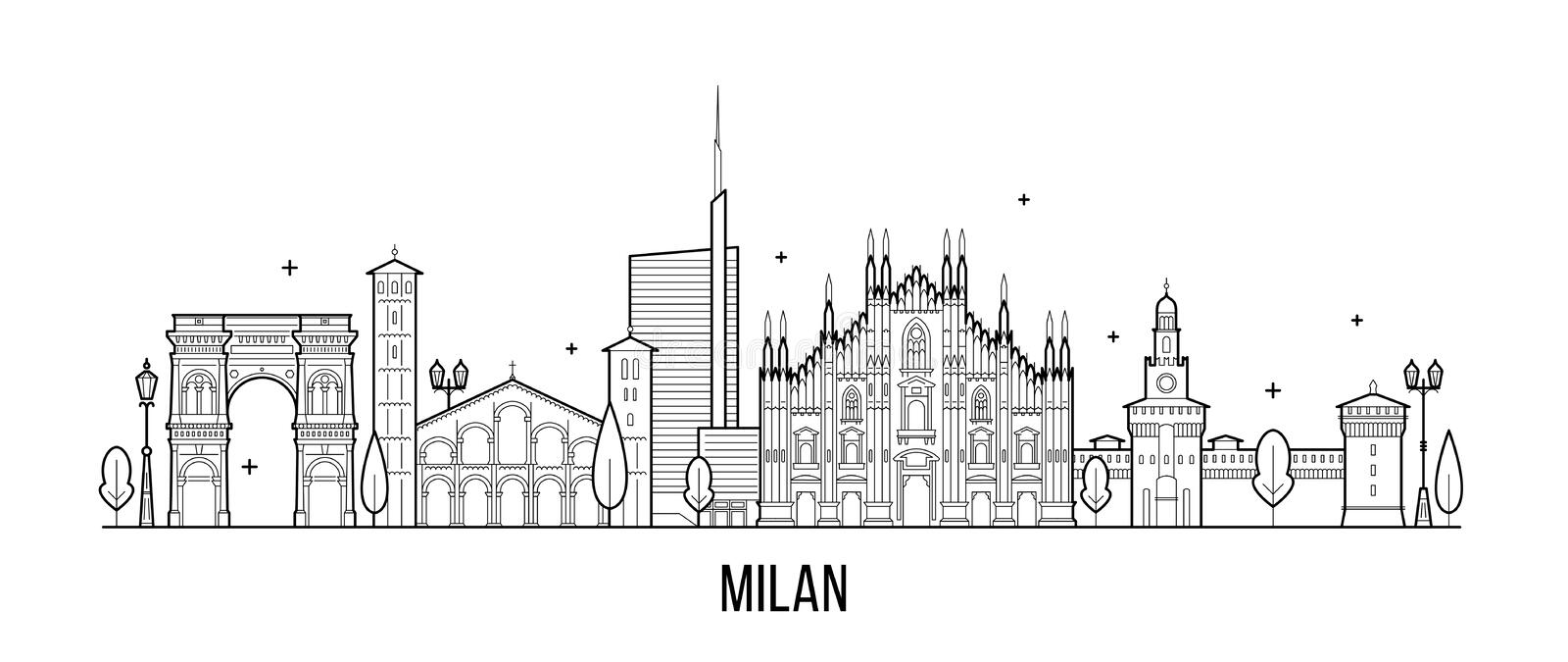di Manuela Ballo
«Alberto Mario Cirese rifondò la storia delle tradizioni popolari e la ricollocò nel contesto di una ricerca universitaria destinata ad un mondo nuovo o, almeno, rinnovabile. E anche nelle lezioni era un maestro della parola e della scena: seppure minuto, aveva un controllo della ribalta, della voce, del gesto, dello sguardo, del dialogo con il pubblico». Fabio Mugnaini, docente di Storia delle Tradizioni Popolari, di Etnologia Europea e di Antropologia della performance nell’Ateneo senese, è stato testimone diretto di quegli insegnamenti: in questa intervista ripensa all’eredità culturale, umana e politica, nel senso più alto del termine, dell’antropologo nato cento anni fa ad Avezzano, morto a Roma il primo settembre del 2011, che a Siena insegnò e fu tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia. «Era ben più che il luogo in cui si studiava, era un punto di riferimento per prendere coscienza e di passioni», ricorda Mugnaini.
Il 9 giugno di cent’anni fa nasceva ad Avezzano Alberto Mario Cirese, uno studioso che ha segnato profondamente la storia dell’antropologia. Lei è parte della sua scuola che proprio a Siena ebbe come diretti seguaci Pietro Clemente e Piergiorgio Solinas. Lei è rimasto, forse, l’unico diretto testimone di quella storia e ora insegna, proprio nella città toscana, quelle che furono alcune delle sue materie. Come ricorda quel maestro in quegli anni decisivi e la sua formazione? E cosa è rimasto nella vostra disciplina del suo insegnamento?
Fa impressione sentirsi inchiodato a questa successione: non ci si sente mai all’altezza dei propri maestri, tanto più quando si è stati oggettivamente parte di una filiera che ha svolto una funzione fondativa, quale quella impiantata da Cirese nel suo percorso di insegnamento a Cagliari, a Siena e poi a Roma. Tre luoghi – cui aggiungere Città del Messico e Colima – dove i suoi insegnamenti e la sua impronta personale hanno sviluppato altrettante “scuole”, gemmate dalle sue lezioni e dai suoi lavori, magari destinate a distinguersi per temi e sviluppi teorici, ma accomunate dal rigore metodologico che è stata la sua cifra e dal procedere dagli stimoli del suo “multiforme” ingegno. Essere eclettici è facile: basta essere superficiali; esserlo come ha fatto Cirese, coprendo ambiti distanti – dalla poesia popolare ai musei, dalla tecnologia / cultura materiale ai linguaggi della parentela, dalla panificazione alla divisione del lavoro domestico, dall’informatica alla fiabistica lasciando in ciascuno di questi un segno indelebile e produttivo, aprendo sempre un dialogo multidisciplinare con la filosofia, la filologia, la storia, l’informatica, è segno di un talento di raro spessore.
Io non sono mai stato un suo confidente, sebbene abbia avuto molte occasioni di incontro (e persino di scontro, come accade con un maestro come si deve). Aver condiviso parte della sua permanenza in Messico, 1986, aggiunse un tocco di familiarità cui sono rimasto sempre molto affezionato, ma a Siena, oltre a Pietro Clemente, che gli successe sulla cattedra di Roma, Pier Giorgio Solinas, Maria Luisa Meoni, Carlo Fini, Riccardo Putti (che è già più vicino alla generazione mia e dei miei attuali colleghi) sono testimoni ben più autorevoli per ricchezza di argomenti e aneddoti, avendolo avuto come maestro prima e poi interlocutore diretto.
Lei cosa insegna?
Io continuo a insegnare storia delle tradizioni popolari, una materia che Cirese praticò e rifondò, ripulendola dai cascami di un romanticismo localistico, sopravvissuto alla strumentalizzazione che ne fece il fascismo, e ricollocandola nel contesto di una ricerca universitaria destinata ad un mondo nuovo o, almeno, rinnovabile. Cirese ogni tanto veniva a Siena a tenere seminari o presentare le sue ricerche; era, per noi studenti, come la materializzazione di un’entità. Per di più le sue lezioni erano di una chiarezza cristallina, impegnative e motivanti e ne restavi conquistato, sebbene non uscisse mai dal ruolo del professore. Cotanto rigore fece sì che anche la disciplina che io insegno attualmente poté accreditarsi come un ambito del sapere specialistico, distinto dalla passione amatoriale e inquadrato solidamente entro l’ambito dell’antropologia culturale. Guardando indietro, oggi si vede come il suo impianto abbia dovuto adeguarsi ai mutamenti globali, ma anche la svolta più recente, quella che vede le tradizioni popolari confluire nel cosiddetto “patrimonio culturale immateriale”, lo ebbe come osservatore critico.
Il 6 di maggio del 2010 Alberto Mario Cirese tenne la sua ultima lezione senese trattando un argomento a tutti voi molto caro, “Mezzadri e Musei”. Grazie al lavoro del Centro, diretto allora da Riccardo Putti, quelle immagini sono state registrate e rimangono un prezioso patrimonio dell’ateneo. In occasione dei cento anni dalla sua nascita quelle immagini non potrebbero esser riproiettate agli allievi di oggi ricordando così il grande studioso sia alla cultura cittadina che all’intero ateneo? E comunque avete in programma altre iniziative per ricordarlo?
Riccardo Putti ha messo al sicuro molte ricche testimonianze del magistero di Cirese: oltre al video che è accessibile a tutti sul sito di Ars Videndi, ci sono molti altri momenti fissati su nastro, che arricchiscono il patrimonio archivistico dell’area antropologica. Cirese era del resto un maestro della parola e della scena: seppure minuto, aveva un controllo della ribalta, della voce, del gesto, dello sguardo, del dialogo con il pubblico che rende tuttora molto godibili questi documenti. A Siena – ma non solo – il ricordo di Cirese vive sui due diversi filoni: quello della memoria personale, aneddotica e affettiva, e quello dell’eredità di pensiero, di metodo. Gli studenti di antropologia che si formano qui ne sanno grazie alla sua presenza nella nostra didattica, quelli che ci raggiungono per la laurea magistrale lo scoprono e scoprono quanto molte formule attualmente di moda, magari importate dall’antropologia anglo-americana, erano più o meno esplicitamente già presenti nei suoi lavori.
Per noi, parlare agli studenti di Cirese non significa “commemorarlo”, ma farci i conti; nella didattica circola come uno dei grandi classici, da attualizzare ovviamente, ma sempre vivi. Nella circostanza dell’anniversario, ovviamente, faremo la nostra parte contribuendo alle iniziative che stanno maturando, da Firenze a Roma, grazie anche alla dedizione con cui Pietro Clemente coltiva il suo ricordo e la sua eredità.
Cirese fu uno dei padri fondatori di quella Facoltà di Lettere e Filosofia a Siena della quale abbiamo festeggiato, qualche mese fa, i suoi primi cinquanta anni. Cosa si ricorda di quella facoltà nella quale, peraltro, lei si è laureato? E di quegli anni di studio che era sempre unito, da quel che si sa, a pratiche di ricerca sul territorio?
La facoltà di cui Cirese fu il primo preside è stata per moltissimi ben più che il luogo in cui si studiava; è stata un punto di riferimento per prendere coscienza, scoprire delle passioni: penso al teatro, al cinema, alla poesia, all’archeologia, alla stessa antropologia: tutti campi del sapere che raramente si incontrano a scuola e che esplodono, a vent’anni, come delle vere e proprie scoperte. Anche la letteratura stessa, grazie a Scalia, Melis, Prete oppure a Fortini, a Luperini, Briosi, si rivelava diversa da quanto i manuali ci avevano convinti che fosse.
Cirese fu presente per pochi mesi, ma lasciò quell’impronta di dialogo tra campi vecchi e nuovi (la storia dell’arte, la filosofia, l’antropologia), che sarebbe rimasta come cifra delle scienze umanistiche degli anni a venire.
La facoltà sarebbe stata – fino a quando le opinabilissime riforme universitarie lo hanno consentito – la casa di chi si cercava, di chi aveva voglia di scoprire il mondo e lo incontrava – spesso anche letteralmente – per i corridoi o nel giardino di Fieravecchia e San Galgano. Era anche il laboratorio in cui convergevano i risultati di un’attenzione al territorio che gli archeologi, gli storici, gli storici dell’arte e, ovviamente, gli antropologi coltivavano in piena legittimità anche nei confronti di ambiti di ricerca più distanti, esotici o blasonati. Per gli antropologi, in particolare, il territorio forniva testimonianza diretta del passato ricco quanto profondo della mezzadria, articolato in tradizioni espressive (il bruscello, le maggiolate, la tradizione orale), forme sociali (le grandi famiglie polinucleari), in posizionamenti ideali (le lotte, la partecipazione alla Resistenza), eredità materiali (le grandi case coloniche, gli strumenti autocostruiti, l’agronomia) simboliche (le credenze, la religiosità, la concezione del tempo) ed estetiche (il senso del bello, l’ironia, la misura). La facoltà era attraversata da domande che venivano dal territorio e rispondeva: pubblicare con un editore locale non comprometteva, allora e al contrario di oggi, la valutazione della qualità del contributo; mostre, interventi con le scuole, attivazione di musei erano pane quotidiano, pur senza essere ancora etichettati come “terza missione”.
Pochi sanno che Cirese è stato anche molto impegnato in politica, avendo da giovane scritto per uno storico giornale quale l’Avanti ed essendo, poi, stato anche Presidente della Provincia di Rieti. Era un mondo davvero particolare quello nel quale prestigiosi docenti, come lui, si impegnavano direttamente anche in politica e sui temi sociali. Cos’è rimasto, secondo lei, di quel modo di intendere il ruolo di docente e di intellettuale?
Cirese è stato rappresentativo della sua generazione: attratto dalla politica fin da giovane (seppure in quanto figlio della scuola di regime fu in gioventù attratto dalla metafisica fascista), ha posto le basi per consolidare il principio che lo accomunava a Ernesto de Martino, l’altro suo grande coetaneo: fare cultura è fare politica, è restituire dignità, è comprendere le ragioni dei dislivelli culturali e sociali, è ampliare l’orizzonte di ciò che consideriamo umano.
La sua militanza si è espressa in appartenenze che non attribuivano priorità alle strutture di partito, ha assunto impegni di governo localizzati e motivati da ragioni di vicinanza affettiva e di effettiva competenza, in un equilibrio tra pratica accademica e pratica politica che Cirese traduceva nella massima del suo amico sindaco di Rieti, “prima la filologia, poi il socialismo”. Una visione della politica non abbacinata dall’ideologia e incline alla riflessione autocritica: tanto che gli ultimi suoi anni, partendo dalla caduta del muro di Berlino, sono stati segnati da un filone di recriminazione quasi fossero sue le responsabilità storiche del “socialismo realizzato”. Cirese non ha mai smesso di mettere sul piatto le sue idee, neppure in questa ultima fase di ripensamento autocritico; è stato un intellettuale testimone e testimoniante: ciò che la cosiddetta “professionalizzazione” della politica sembra oggi respingere e, dall’altra parte, ciò che la crescente burocratizzazione della ricerca scientifica e umanistica mortifica misconoscendone il valore negli algoritmi gestionali e valutativi. Io sono rimasto tra i pochi docenti a mantenere il manuale di Cirese nel programma d’esame del mio corso di Storia delle tradizioni popolari. Portare gli studenti di oggi a leggere le sue pagine di cinquant’anni fa apre degli scenari inattesi, consente loro la comparazione tra ciò che essi immaginano della ricerca, della disciplina, del ruolo dell’intellettuale e ciò che il nostro grande vecchio – come lo chiamo a lezione- ha saputo incarnare e trasmetterci.