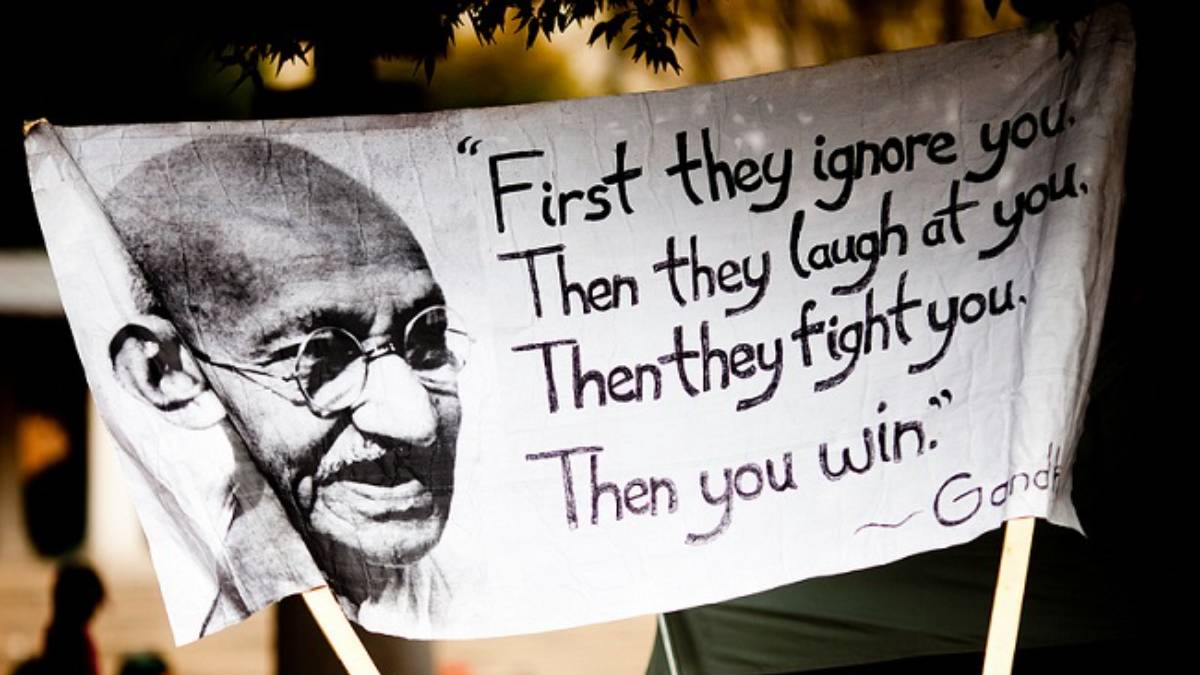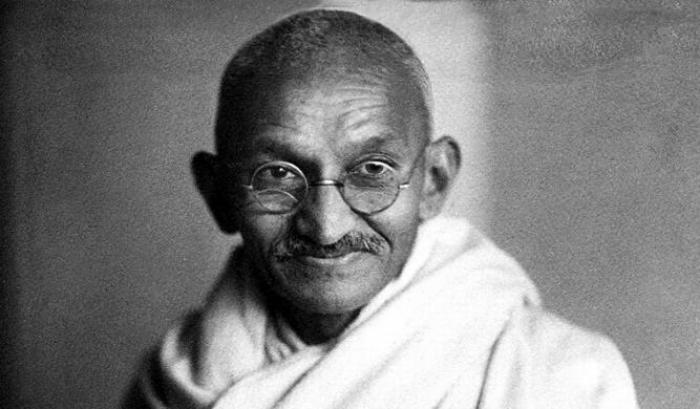di Giada Zona
Era il 2 ottobre 1869 quando nasceva Mahatma Gandhi che fece della rivolta non violenta, la “satyagraha”, il suo tratto distintivo. La protesta pacifica di Gandhi consisteva nel violare le norme per affermare valori sociali: una pratica che, ancora oggi, trova apprezzamenti da alcuni e critiche da altri.
Gli apprezzamenti provengono da chi, spesso inconsapevolmente, oggi prende spunto da pratiche gandhiane. È quanto è accaduto a Bologna il 22 settembre, quando, durante lo sciopero generale nazionale per Gaza, i manifestanti hanno bloccato la tangenziale. L’azione, contraria a quanto disposto nel ddl sicurezza, ha provocato così la reazione delle forze dell’ordine con fumogeni e quattro arresti.
Infatti, il ddl sicurezza prevede un aumento dei controlli e delle sanzioni nei confronti dei manifestanti. Le pene sono diventate più severe per chi blocca la strada: se prima la sanzione era una multa tra i 1000 e i 4000 euro, oggi è prevista la reclusione fino ad un mese, oltre una multa fino a 3mila euro. Bisogna capire se il problema sia la necessità di sicurezza qui professata o l’esistenza delle stesse manifestazioni, a prescindere dal loro carattere pacifico.
Scendere in piazza a manifestare e far sentire la propria voce, in un’epoca in cui soprattutto i giovani sono accusati di cinismo e passività, è di per sé un atto di resistenza. Certamente far diventare la protesta un momento di violenza è segno di inconsapevolezza e incoscienza; allo stesso modo, però, penalizzare il dissenso pacifico mette a rischio il diritto di manifestare.
Molti considerano il ddl sicurezza una minaccia contro le manifestazioni pacifiche, poiché impedisce la piena espressione della protesta. Così, l’eredità di Gandhi, simbolo della lotta pacifica contro il razzismo, il colonialismo e le disuguaglianze, trova degli ostacoli nella società odierna. Nella storia più recente a portare avanti l’esempio della satyagraha fu, tra i diversi leader, Nelson Mandela che, con il partito dell’African National Congress, tutelava i diritti della popolazione nera contro l’apartheid, un sistema di segregazione razziale.
Gandhi, e Mandela dopo di lui, oggi non ci sono più. E se molti considerano la Global Sumud Flotilla una pratica gandhiana, stanno commettendo, benevolmente, un errore. Quella che fin dall’inizio è stata definita come una missione umanitaria e pacifica –che probabilmente sarebbe tanto piaciuta a Gandhi– non sta violando le norme. E’ certamente una forma di protesta non violenta, ma non c’è nulla di illegale.
La “satyagraha” esiste ancora oggi e dimostra l’espressione di una voce dal basso. Non siamo soltanto una “società liquida”, come scriveva Zygmunt Bauman. La storia delle sottoculture insegna che il desiderio di aggregarsi, di unirsi e di protestare non si spegne così facilmente. La ribellione c’è e ci sarà: cambiano le forme e i modi, ma chi ha a cuore certi ideali continuerà a portarli avanti.
Ecco perché il diritto di protestare deve essere ascoltato e coltivato. Da un lato, la società deve scendere in piazza senza creare disordini; dall’altro, la politica deve sedersi ad ascoltare i bisogni dei cittadini e, se necessario, mettersi in discussione.