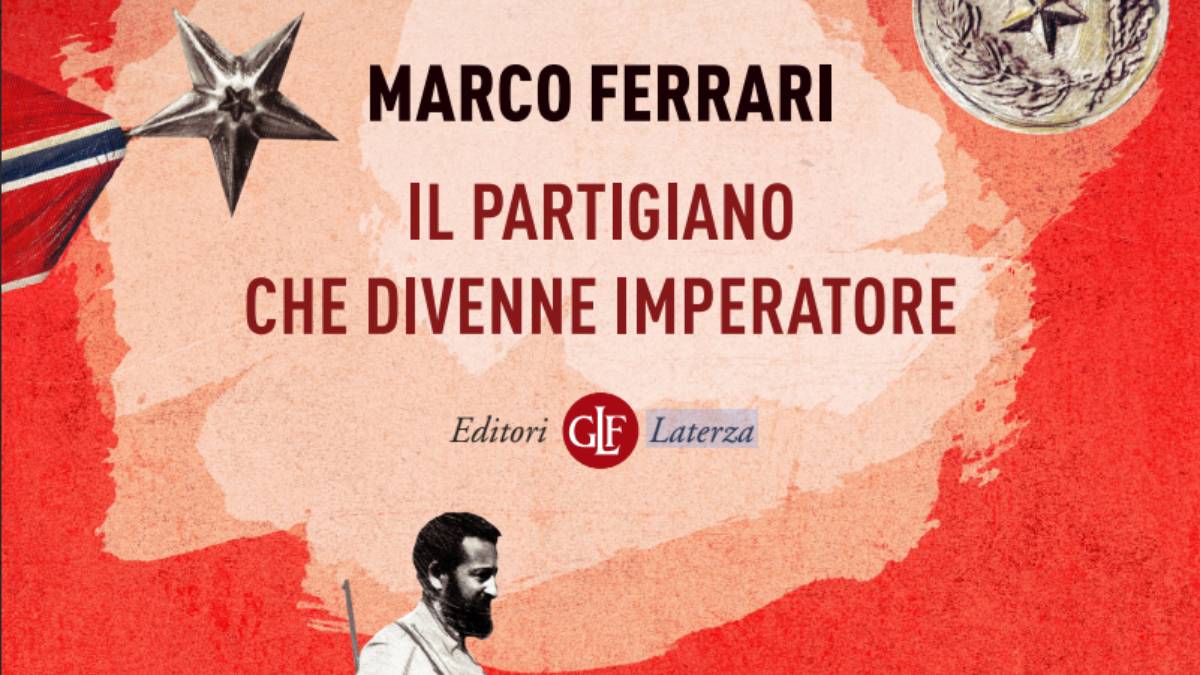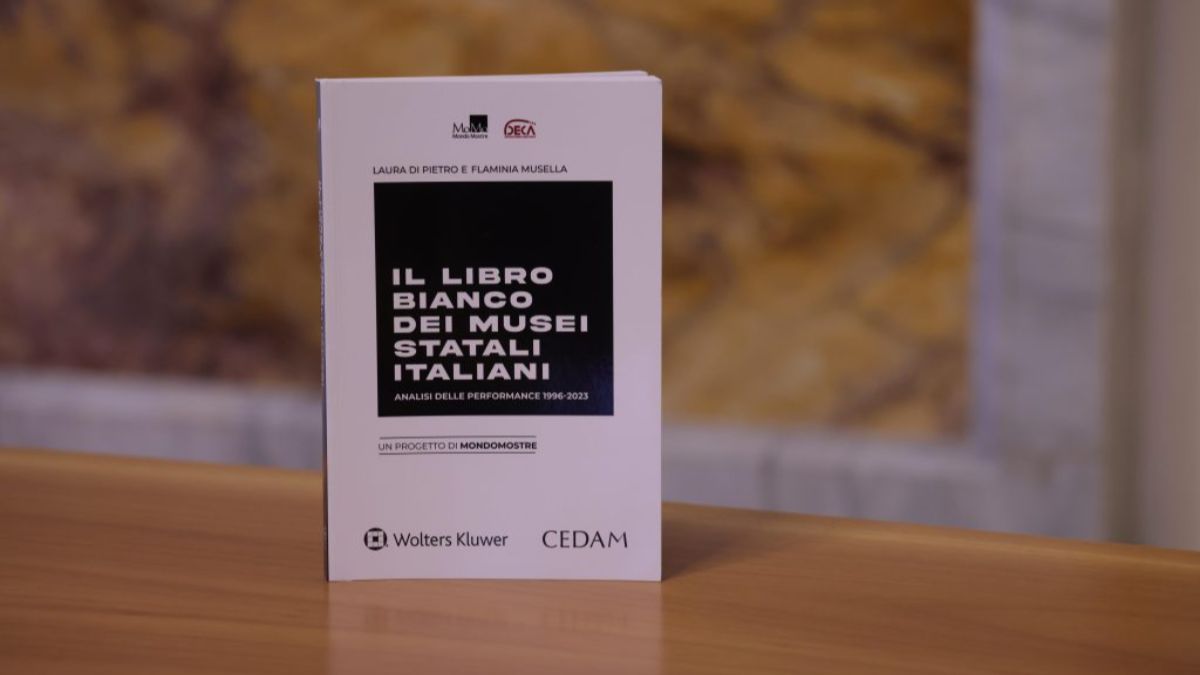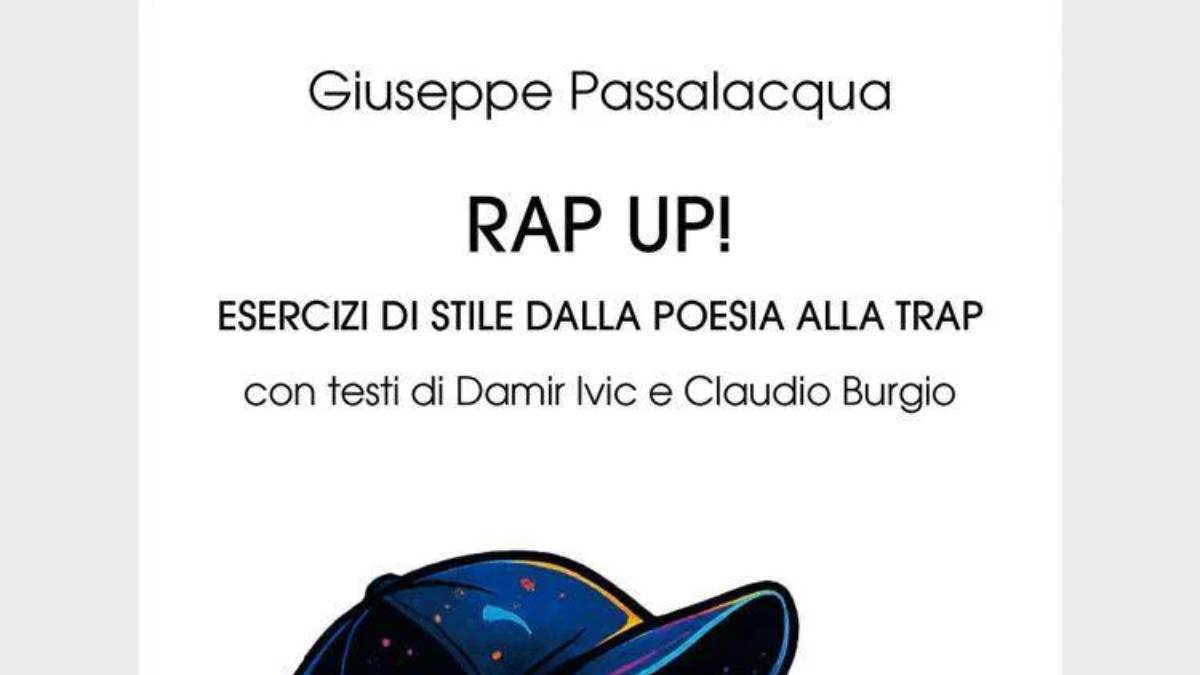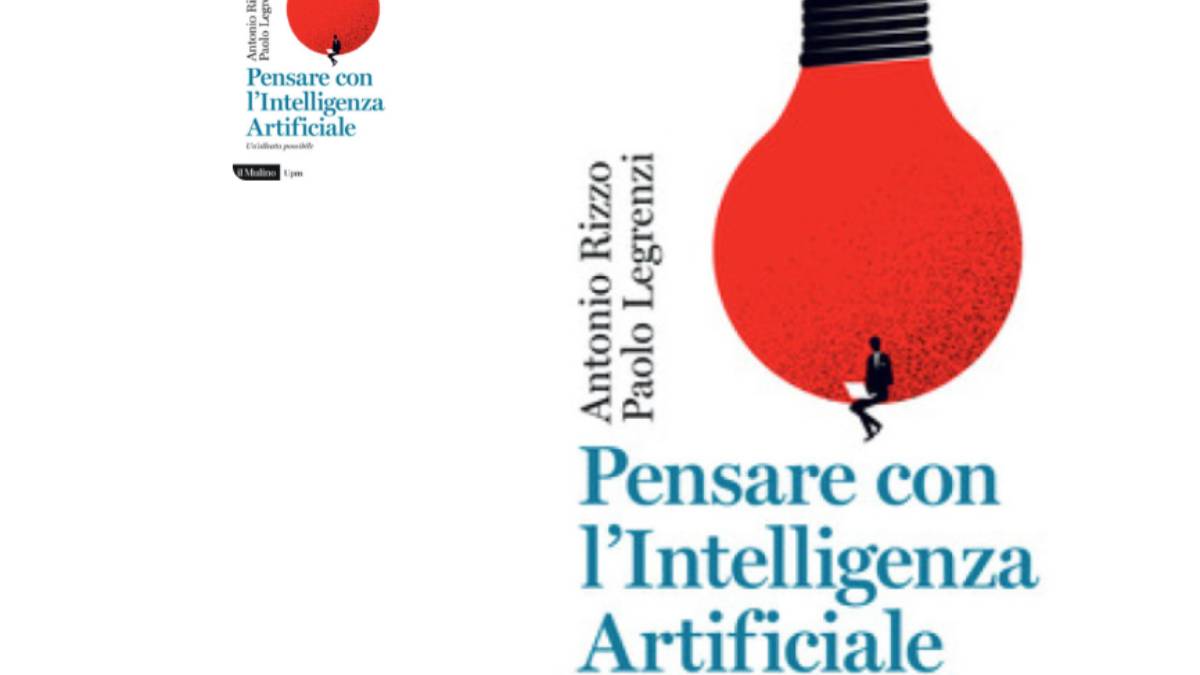di Marco Ferrari*
*giornalista e scrittore
Era un pomeriggio grigio e freddo nell’inverno parigino del 1938. Di Vittorio accese il grande lampadario su cui due lampadine erano spente. In poco tempo la sala riunioni della sede del Partito Comunista d’Italia in esilio si riempì: per primo arrivò il rappresentante dell’Etiopia alla Società delle Nazioni, Lorenzo Taezaz, seguito da una folta delegazione francese composta da Georges Mandel, da poco tempo ministro delle Colonie, dal direttore del suo gabinetto André Diethelm, da Pierre Cot, esponente radicale che aveva buoni rapporti con le organizzazioni comuniste e che era stato ministro del Commercio nel secondo governo Blum, dal colonnello Paul Robert Monnier del Deuxième Bureau, il servizio di informazioni militari.
Fu Di Vittorio a tracciare il quadro della missione che andava delineandosi, diretta all’Etiopia. Raccontò che aveva già reclutato una decina di persone esperte durante la sua permanenza in Spagna, ma che alla fine sarebbero partiti tre o quattro combattenti. Gli altri prescelti, in gran parte personale sanitario, sarebbero stati dirottati in Cina. Per l’Etiopia si stava preparando alla partenza Ilio Barontini, l’eroe della battaglia di Guadalajara, assieme a un altro compagno, Paolo De Bargili, un uomo ombra che usava lo pseudonimo di Paul Langlois. Georges Mandel si disse disposto a mettere a disposizione tutti i canali aperti con la resistenza abissina e il colonnello Monnier confermò che il Deuxième Bureau e pure gli inglesi di stanza in Sudan avevano già avviato contatti diretti con il ras Cherassà e con Abebe Aregai.
“Il partigiano che divenne imperatore”, tra saggistica e romanzo, narra le avventure di quei tre antifascisti italiani, reduci dalla guerra di Spagna, scelti dai servizi segreti francesi e britannici assieme ai dirigenti del Partito comunista per organizzare la resistenza in Etiopia agli occupanti fascisti. Si trattava di Ilio Barontini, Anton Ukmar e Domenico Bruno Rolla. Fu Di Vittorio a scegliersi e fece una cosa giusta: individuò tre persone irregolari, dotate di grande coraggio ma anche di forte immaginazione e quindi capaci di tirarsi fuori con l’ingegno da situazione complicate.
Una storia in cui si respira l’odore acre del Novecento, che potrebbe uscire dalle pagine di Graham Greene. Il partigiano che venne nominato vice imperatore d’Abissinia è appunto Ilio Barontini (Cecina, 28 settembre 1890 – Scandicci, 22 gennaio 1951), perseguitato dal fascismo, fuggì da Livorno nel 1931, raggiunse nell’apparato clandestino del PCd’I a Parigi, si trasferì in Unione Sovietica e nel 1936 fu inviato nella guerra di Spagna diventando l’eroe della battaglia di Guadalajara, dove le brigate internazionali sconfissero i fascisti.
A Parigi venne scelto da etiopi, francesi e britannici per quella missione rischiosissima: organizzare le forze partigiane abissine che dovevano resistere alla conquista fascista. Raggiunse le zone sotto il controllo della resistenza attraversando Egitto e Sudan con le credenziali di Hailé Selassié trascritte su fazzoletti di seta per sfuggire al controllo nemico. Nell’estate del ’39 venne raggiunto da Anton Ukmar, ex ferroviere sloveno di Gorizia conosciuto in Spagna, da Bruno Rolla, antifascista spezzino, dal colonnello Paul Robert Monnier del Deuxième Bureau, che morirà poco dopo, e dal segretario del Negus Lorenzo Taezaz.
Mussolini aveva conquistato con l’uso dell’iprite i villaggi e le città più importanti, la ferrovia Addis Abeba-Gibuti e le principali vie di comunicazione, ma una parte considerevole del territorio era ancora in mano agli Arbegnuoc, i patrioti etiopi. Barontini trovò difficoltà nel mettere insieme i diversio ras locali e quindi chiese aiuto al Negus, in esilio a Londra, che lo nominò appunto suo vice. Così, dotato dello scettro imperiale, il comunista di Livorno tenne a bada i vari ras, organizzò un esercito di 250 mila resistenti, scelse la tattica di piccoli gruppi offensivi di 15-20 combattenti per gli attacchi ai fortini fascisti, portò a termine missioni importanti e pubblicò un giornale bilingue, “La voce degli Abissini”, tanto da diventare una leggenda.
La missione terminò nel giugno 1940, quando i tre italiani intrapresero la via del ritorno tra malattie e assalti di predoni. Si ritrovarono miracolosamente vivi a Khartum dove scattarono l’unica fotografia che li ritrae tutti e tre insieme.
Rientrato in Europa, Barontini organizzò la resistenza prima in Francia e quindi in Emilia-Romagna e partecipò alla liberazione di Bologna. Nel 1946 per il PCI divenne deputato all’Assemblea Costituente nella circoscrizione di Pisa e Livorno e, nel 1948, venne eletto al Senato della Repubblica, dove fu segretario della commissione Difesa. Venne altresì nominato cittadino onorario della città di Bologna, decorato dalle forze alleate con la Bronze Star Medal e dall’Unione Sovietica con l’Ordine della Stella Rossa. Morì in un incidente automobilistico a Scandicci nel 1951 all’età di 60 anni, sulla strada per Firenze dove si stava recando a portare il saluto dei comunisti livornesi alla federazione fiorentina del partito, assieme ad altri due dirigenti di valore come Otello Frangioni e Leonardo Leonardi.
Al suo rientro in Francia Anton Ukmar venne internato a Vernet d’Ariège e poi a Castres, da cui evase l’8 settembre 1943. Raggiunse la resistenza in Venezia Giulia, nel 1944 fu inviato dalla dirigenza del partito comunista a Genova e divenne comandante della VI Zona Operativa Ligure dei partigiani Garibaldini con sede a Carrega Ligure, in provincia di Alessandria. Partecipò alla liberazione di Genova, tanto che gli venne conferita la cittadinanza onoraria della città della Lanterna, oltre alla Bronze star statunitense, la Medaglia d’oro alla Resistenza del governo italiano e altri riconoscimenti da parte del governo jugoslavo.
Al rientro dall’Africa, nel marzo 1940, Domenico Rolla fu internato nel campo francese di Vernet d’Ariege, tentò il rientro in Italia ma venne arrestato al Ponte Unione, a Mentone il 5 aprile del 1944 e tradotto nelle carceri giudiziarie della Spezia a disposizione del Tribunale Speciale. Il 24 luglio fu condotto a Regina Coeli ma, ai primi del 1944, con uno stratagemma riuscì a evadere e a raggiungere Avezzano in Abruzzo, dove partecipò alla Resistenza come commissario politico, con il nome di “Carlo”. Nel dopoguerra tornò alla Spezia entrando a far parte della segreteria provinciale del Pci quale responsabile dell’organizzazione e poi alla direzione nazionale del partito. Morì il 9 giugno 1954 a soli 46 anni. È sepolto nel cimitero di Baccano, in provincia della Spezia.