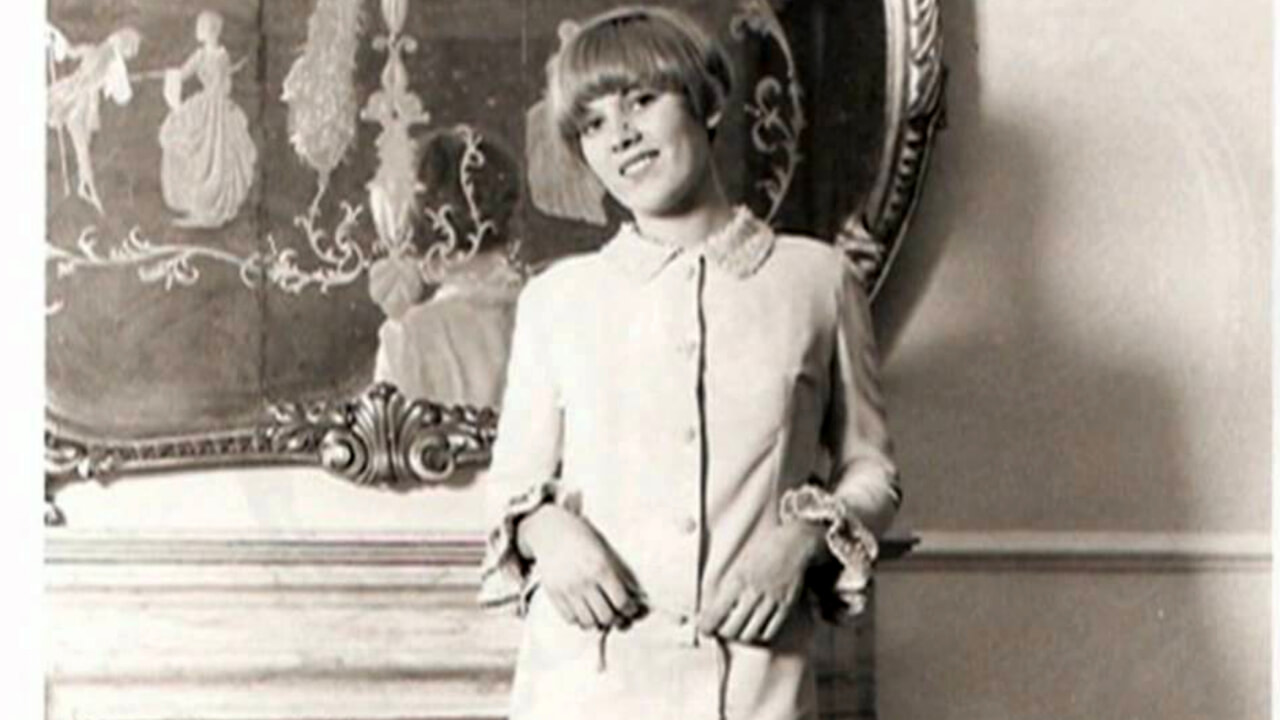di Giada Zona
Mentre ascoltiamo musica comodamente sul nostro smartphone, magari su Spotify o piattaforme simili, il nostro consumo diventa fonte di profitto. A guadagnarci, però, sono soprattutto quest’ultime e gli artisti già noti. Su Spotify – giusto per fare un esempio – dobbiamo ascoltare almeno 30 secondi di un brano per generare profitti. Gli artisti non possono certo ignorare questa regola, creando talvolta brani più corti che colpiscono fin da subito, in modo da raggiungere tale lasso di tempo. Siamo di fronte a logiche fortemente orientate al guadagno, che finiscono per dettare il ritmo ai musicisti e ai loro testi, dove il valore artistico deve intrecciarsi con le nuove richieste del mercato.
Un problema che non solo sta cambiando parzialmente il repertorio musicale, ma crea anche disparità di guadagno. Spotify paga tra 0,003 e 0,005 dollari per stream: se quindi la regola è più ascolti fai e più guadagni, gli artisti di nicchia trovano maggiore difficoltà ad emergere e a competere in un sistema che privilegia chi ha già ottenuto successo. La durata delle canzoni è dunque cambiata, soprattutto quella dei brani pop che durano sempre meno, ma è un fenomeno complesso dove anche la soglia dell’attenzione scesa ad otto secondi ha la sua rilevanza. Diventando sempre più corti e rischiando così di diventare merce, i brani si piegano alle domande del mercato e prendono parte a un capitalismo che, sebbene invisibile, è dietro le piattaforme che usiamo tutti i giorni. E sì, anche quelle musicali.
Se da un lato sono le logiche della piattaforma a stabilire le regole del gioco, dall’altro prendono vita spazi alternativi come Bandcamp, un servizio musicale fondato in California che si pone l’obiettivo di dare maggiori profitti agli artisti che, all’interno della stessa piattaforma, instaurano un rapporto con i loro fan. Un rapporto che può andare ben oltre la musica, come avvenne nel 2020 con iniziative che hanno sostenuto il movimento “Black Lives Matter”. Una parte dell’industria musicale ha quindi riconosciuto e ha reagito contro il capitalismo dietro le piattaforme. A dimostrarlo, oltre il sopracitato caso, anche la vicenda accaduta il mese scorso, quando il cofondatore di Spotify Daniel Ek ha finanziato con 600 milioni l’industria militare suscitando una risposta dagli artisti, alcuni dei quali hanno tolto i loro brani dalla piattaforma. Attuando così quelle che Michel De Certeau, antropologo francese, chiamava “tattiche”, atti di resistenza praticati da individui più svantaggiati rispetto a coloro che, come Daniel Ek, detengono il potere.
Se oggi c’è il digitale, con le piattaforme sempre più discusse e influenti, ieri c’era l’analogico, da qualche tempo tornato in auge. Prima con il 78 giri e dopo la seconda guerra mondiale con il 45 giri i brani dovevano rispettare i limiti temporali imposti dal vinile; poi arrivarono gli LP a 33 giri, dove l’artista poteva registrare anche un album, oltre a musicassette e CD, nuove tecnologie che garantivano una maggiore durata delle tracce. Tra i più famosi ricordiamo “La Locomotiva” di Guccini con una durata di ben 8 minuti e 17 secondi, “Hey Jude” dei Beatles 7:11 minuti, “Another Brick In The Wall” dei Pink Floyd 8:27 minuti. Giusto qualche capolavoro. Anche se minor durata non vuol dire minor significato e profondità –basti pensare a “Blowin’ In The Wind” di Bob Dylan – è evidente a tutti, piattaforme e artisti in primis, che le canzoni, soprattutto pop, durano sempre meno.
Notevolmente cambiato nell’epoca digitale, il mondo musicale ha fatto i conti con le innovazioni che doveva, deve e dovrà affrontare. E i musicisti non sono solo artisti, ma anche utenti con nuove responsabilità, come quella di decidere se conformarsi alle regole delle piattaforme o sottrarsi, se aggirarle o crearne di nuove.