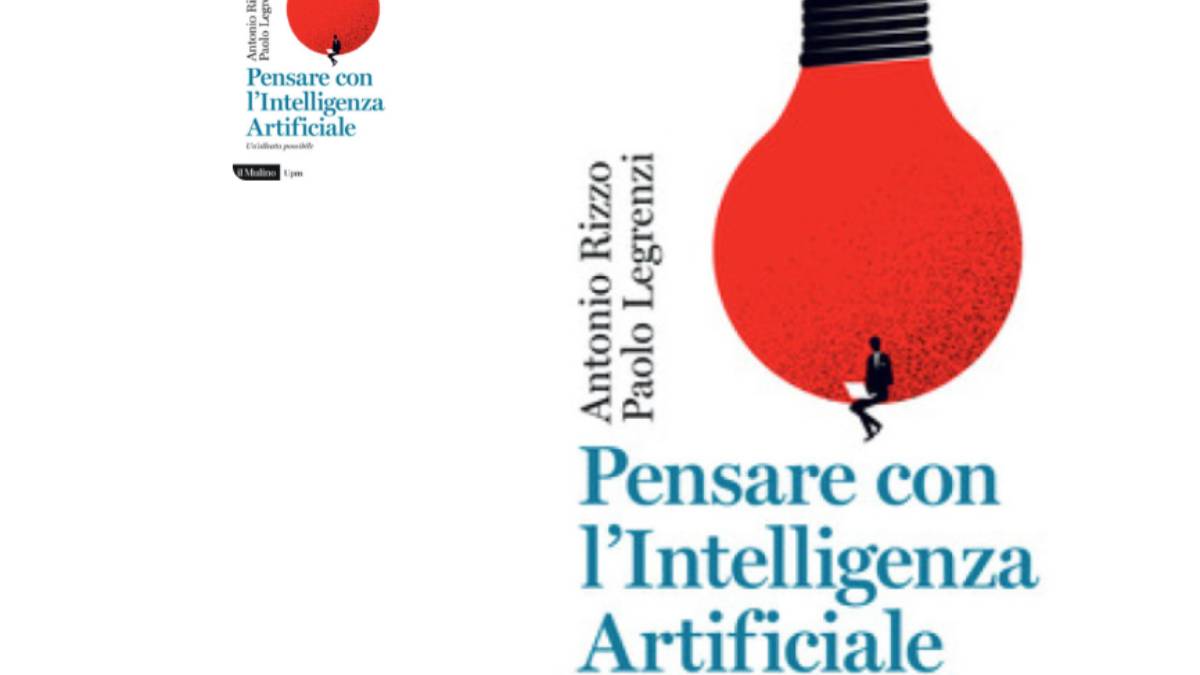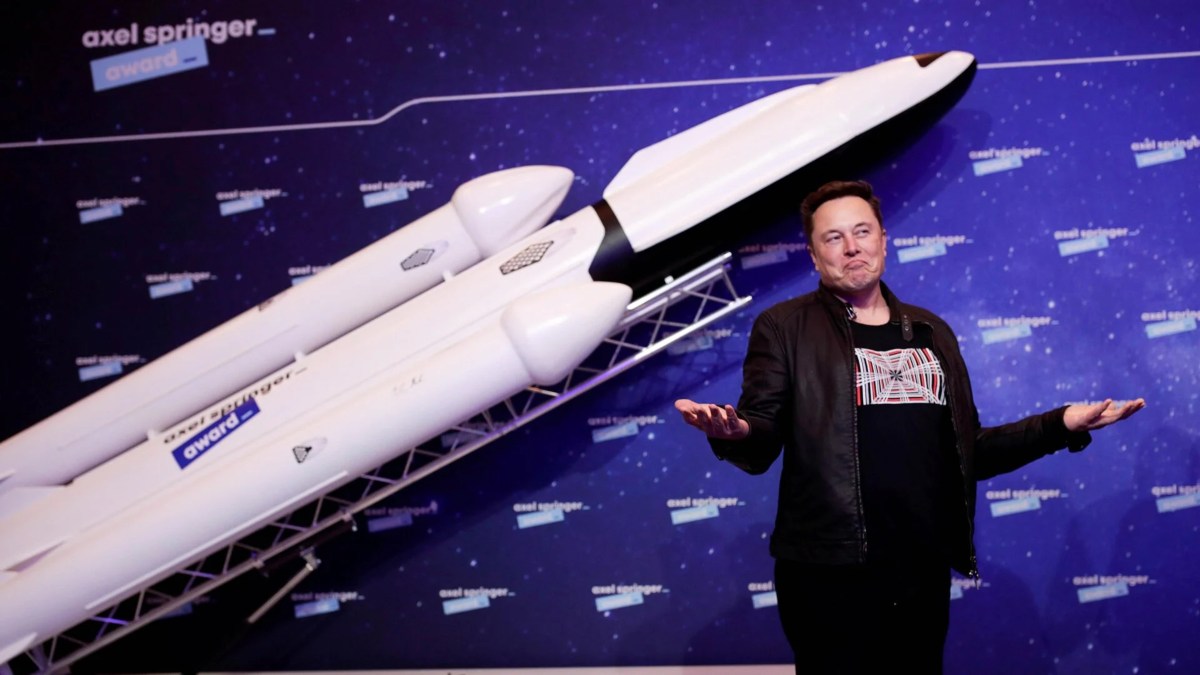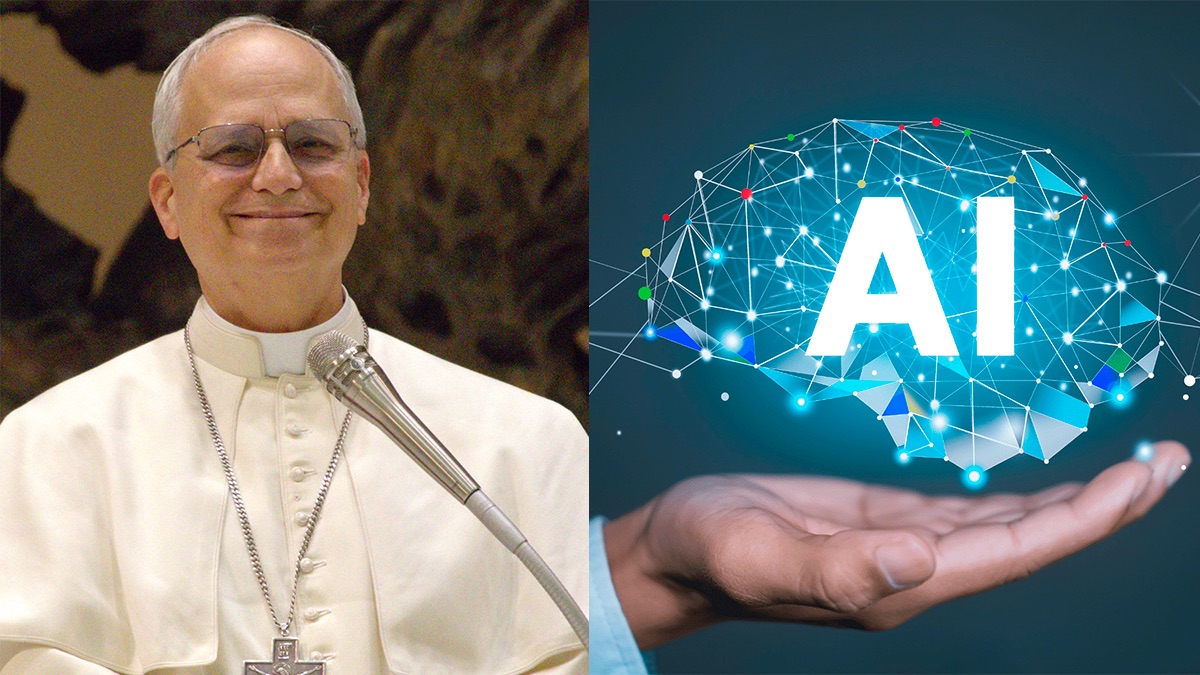di Lorenzo Lazzeri
Che la relazione tra uomo e macchina stia evolvendo da un modello di Comando a uno di Dialogo è innegabilmente chiaro e non più sottovalutabile per inquadrare cosa stia accadendo nell’era dei Large Language Models (LLMs). Nel libro Pensare con l’intelligenza Artificiale: un’alleata possibile di Antonio Rizzo e Paolo Legrenzi, edito da Il Mulino nelle settimane scorse, il professor Antonio Rizzo presenta questo momento come una “svolta epocale”, un cambiamento di paradigma che egli definisce l’Intelligenza Aumentata (IA). È proprio questa rivendicazione di “novità” che innesca un nuovo pensiero critico, una rivalutazione di quanto noi conosciamo di cibernetica attraverso la lente delle scienze cognitive.
Sebbene la realizzazione tecnica di un “partner conversazionale” sia inedita, l’idea di Intelligenza Aumentata non lo è. Il concetto di sinergia tra intelligenza umana e artificiale viene fatta risalire a figure seminali come J.C.R. Licklider, che già negli anni Sessanta teorizzava l’augmentation come alternativa all’automazione, ipotizzando sistemi che non sostituissero l’uomo, ma lo supportassero amplificandone il pensiero.
La critica riguarda la sua definizione: il saggio non presenta gli LLM e il passaggio da comando a dialogo con la macchina come una svolta epocale, bensì come la realizzazione di una storica ambizione della scienza informatica, ora resa possibile dalla potenza dei Transformer. L’applicazione del concetto di intuizione, con riferimento agli scritti di Kahneman, ai Large Language Models (LLMs) è un elemento chiarificatore e costituisce uno dei contributi psicologici più forti del libro, ma lo stesso ragionamento, che porta a parlare di dialogo come soluzione, non è che la più recente declinazione di una diatriba datata che parte già dagli anni sessanta.
Gli autori sfruttano brillantemente la metafora del “dialogo” e del “partner conversazionale” per rendere l’IA accessibile e per sottolinearne il potenziale didattico e clinico, in una scelta retorica efficace che introduce però il rischio di una pericolosa antropomorfizzazione della tecnologia.
Gli LLM, come lucidamente spiegato in un colloquio con uno degli autori, Antonio Rizzo, non hanno intenzionalità, coscienza o una vera comprensione semantica; sono solamente modelli statistici di previsione del prossimo token. Un “dialogo” con un LLM è un mero simulacro di conversazione e non uno scambio tra pari. L’eccessiva enfasi sulla natura di partner rischia di minimizzare la necessità di un distacco critico da parte dell’utente, non permettendo di analizzare e tener presenti delle caratteristiche intrinseche di queste “macchine pensanti”, prive di giudizio e strutturalmente suscettibili ad allucinazioni e distorsioni.
Il saggio è sovraccarico di contesto storico. Gli autori suddividono il testo in due ampie sezioni, dedicano una di queste, circa metà volume, a una digressione tecnica sull’evoluzione dell’IA, rallentando l’accesso alla tesi più interessante e centrale e lo fanno partendo dal neurone di McCulloch-Pitts per arrivare ai Transformer.
Ci si chiede se la lunga ricostruzione storica, che include i limiti del percettrone e l’evoluzione delle GAN, fosse essenziale per sostenere la tesi filosofica e applicativa della seconda parte. Una sintesi più concisa della sezione dedicata all’evoluzione dell’AI, avrebbe potuto liberare spazio prezioso per un’esplorazione più ricca e diversificata di quella parte dedicata all’Intelligenza Aumentata, che avrebbe così potuto beneficiare di ulteriori casi d’uso oltre a medicina e didattica, arricchendo così il campo di applicazione di questo nuovo paradigma del dialogo e risolvendo questa sua disproporzione strutturale.