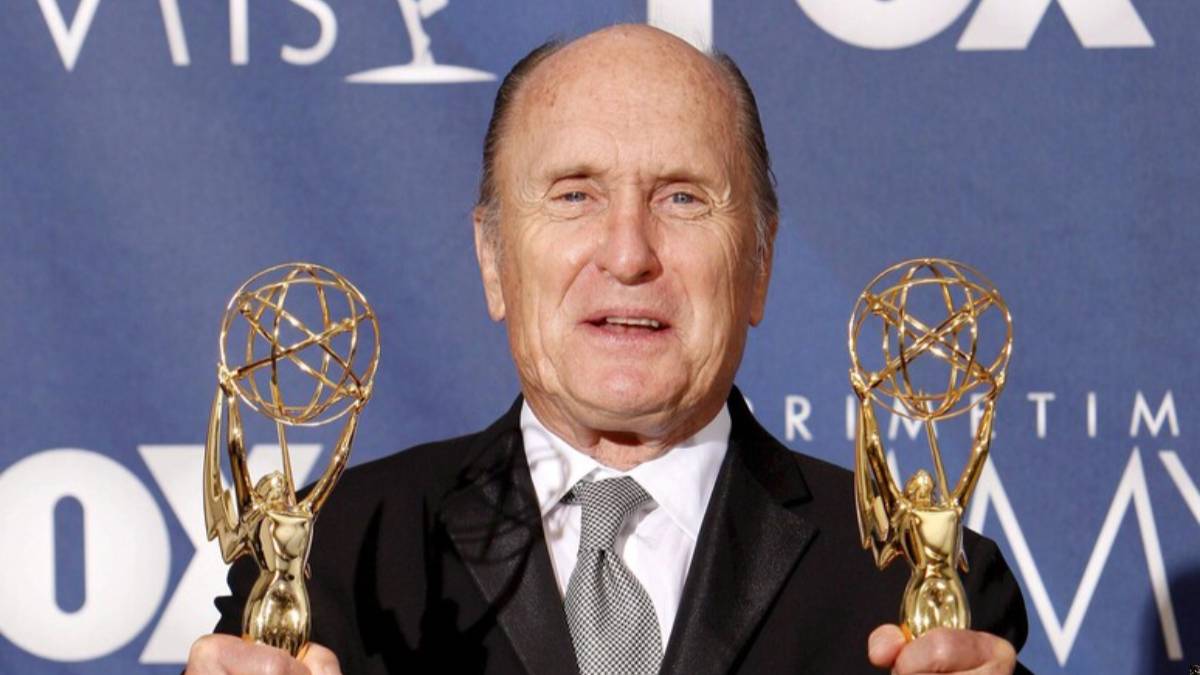di Luisa Marini
La voce di Hind Rajab, scritto e diretto da Kawthar ibn Haniyya, è uno di quei film che meritano la definizione “necessario” per il suo valore di denuncia e impegno civile, oltre che per il suo alto livello tecnico e artistico, e che gli hanno fatto conquistate il Leone d’Argento alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Visto da chi scrive in una sera di un giorno feriale in una sala completamente vuota, forse perché in lingua originale sottotitolata (il che a mio parere crea maggiore adesione all’opera), consiglio vivamente di recuperarne la visione nei cinema che lo stanno ancora proponendo.
La pellicola è girata in forma di kammerspiel, ambientato nella centrale operativa della Mezzaluna Rossa a gennaio di quest’anno, durante la nota situazione della bambina palestinese a Gaza che chiese soccorso bloccata in auto con i cadaveri delle cugine e degli zii uccisi dalle bombe. L’operatore Omar e la responsabile Rana, supportati dalla psicologa del gruppo, facendo i conti con la propria stanchezza, disagio e fragilità, dialogano a turno con delicatezza con la bambina nello sforzo di confortarla, mentre le promettono di farla salvare da aiuti che non arriveranno mai. L’ambiente claustrofobico esce infine in esterno, emblematicamente, solo con le immagini di repertorio del tragico epilogo, che coinvolse anche l’ambulanza inviata in soccorso.
Questo film non si limita a narrare, ma rende lo spettatore testimone della realtà, stimolando una profonda riflessione e una presa di coscienza. La bambina diventa il simbolo del genocidio di un intero popolo, sua madre, col velo azzurro e il fratellino accanto, rassegnata ma dignitosa nel suo dolore, richiama la Pietà cattolica.
Lo spettatore è coinvolto in un rapporto intimo con la storia. Quando non vediamo, soprattutto parzialmente, o ascoltiamo ad esempio la radio, il nostro cervello fa lo sforzo di completare le informazioni mancanti attraverso l’immaginazione. La felice scelta registica di creare coinvolgimento emotivo in chi guarda attraverso l’uso del sonoro fa leva su questo, e la scelta di mostrare in primo piano, sullo schermo nero, la traccia audio dei veri file della voce della bambina palestinese, è tanto semplice quanto potente.
A far da cornice, i rumori di guerra fuori campo e le voci indistinte, che passano sempre attraverso il telefono: l’apparecchio-filtro con l’esterno, simbolo della comunicazione, in questo caso necessaria perché mezzo per salvare vite umane, rimanda la soluzione in un contrappasso ripetuto, scena dopo scena, gestendo le reazioni e le speranze degli operatori. È una macchina che tiene in pugno gli esseri umani, che si ribellano.
È emblematica la scena in cui il coordinatore delle missioni di aiuto, inizialmente rigido e impopolare ma obbligato a seguire delle regole imposte, spiega la complicazione di richieste e approvazioni incrociate tra Croce Rossa, Ministero della Salute ed esercito israeliano allo zio che chiama dalla Germania, disegnando con un pennarello sul vetro che divide il suo ufficio dalla sala: alla fine, la camera inquadra il simbolo dell’infinito.
Ma il film fa passare anche un messaggio simbolico riguardante l’umanità che passa attraverso l’immagine del volto: all’inizio Omar, sconvolto dall’uccisione in diretta telefonica della cugina di Hind mentre ci stava parlando, riceve dalla psicologa una sorta di post-it con la sagoma di una donna senza volto, da appendere sulla sua postazione, come a dire “riprenditi, non la conoscevi, è una delle tante persone che cerchi di aiutare, ed è impossibile farlo con tutti”; successivamente, Rana trova sul web le immagini del volto della bambina con cui parlano e ne ritaglia una, che disperata vuole inserire nella bacheca dei morti, quando hanno perso il contatto. Omar, scoprendo che la bambina è ancora viva, la appende su un vetro della sala, a testimonianza del fatto che ognuno merita speranza. Anche il coordinatore, durante l’ultimo litigio con Omar, gli mostra un foglio con i volti degli operatori uccisi nel corso dei soccorsi e gli dice che, se ne morisse uno di più, ha promesso a sé stesso di lasciare il suo lavoro.
L’impatto emotivo è forte: il problema urgente della salvezza di una bambina indifesa, tragicamente vicina ai soccorritori nel tempo e nello spazio, ci obbliga alla tensione continua di adesione al dramma in corso. Guardando la pellicola sulla comoda poltrona di un cinema occidentale, in contrasto stridente con la storia sullo schermo, lo spettatore prova disturbo fisico ed emotivo per la sensazione di impotenza.
La storia coinvolge perché media la realtà della guerra con la forza del racconto di finzione, stretto di continuo sui corpi degli attori che incarnano l’empatia che hanno avuto i veri operatori e le loro reazioni umane di rifiuto di una situazione di orrore assoluto. Geniale a questo proposito, verso la fine del film, l’uso del cellulare che, nell’atto di riprendere gli attori durante la messinscena, in realtà mostra il video della stessa scena con i veri operatori.
Come a provocarci: riusciamo ancora a capire davvero, oggi, cosa è finzione e cosa realtà, e a distinguerle?