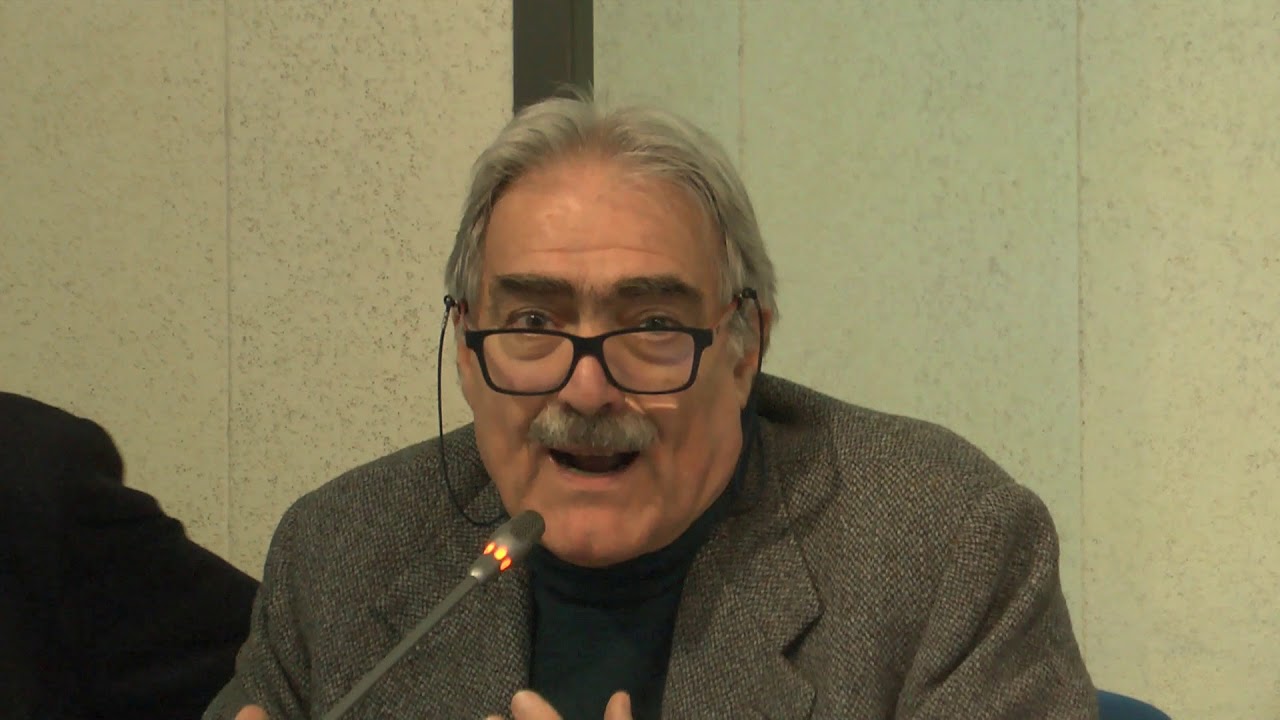di Marco Buttafuoco
Abolire le MMA, le arti marziali miste, sembra più una proposta dettata dall’orrore indicibile della vicenda di Colleferro con l’uccisione di Willy Montero Duarte, più che da una considerazione realistica della realtà. Questo sport, perché di uno sport, per quanto estremo e discutibile, si tratta, sta rapidamente diventando uno dei più seguiti a livello televisivo; non è (o non è solo) una disciplina praticata da pochi adepti in oscure palestre o su ring clandestini, peraltro diffusi. Qualsiasi abbonato di Dazn può accedere, senza particolari problemi, a un’ampia selezione di combattimenti (c’è solo un codice di disarmante semplicità a far filtro per i minori) con commenti qualificati. Dana White, presidente dell’Ufc (Ultimate Fight Championship), la potente e ricca compagnia americana di MMA, è sicuro che nel giro di pochi anni il suo sport diventerà il più popolare a livello mondiale. Una legittimazione politica c’è già stata, molto pesante, e sono le tante foto, anche a tavola (in una appare anche Berlusconi) che ritraggono Putin con Fëdor Emelianenko, il peso massimo ucraino definito il miglior specialista di sempre. Anche Trump si è fatto ritrarre con lo stesso atleta.
Un combattimento di MMA è uno spettacolo di grande crudeltà: sono permesse tutte le tecniche di combattimento, salvo le testate, i colpi sotto la cintura, i morsi e le dita negli occhi. È anche permesso colpire l’avversario a terra. Quello che differenzia questi match da una rissa di strada è semplicemente la tecnica che i contendenti, professionisti ben pagati, dispiegano. Si tratta di veri atleti, preparatissimi sul piano fisico (i combattimenti hanno una durata massima di quindici minuti su tre riprese) e dotati di una quasi disumana capacità di sopportare fatica e dolore. Il ritiro dal match è ammesso solo quando il soccombente è in pericolo di gravi lesioni (soprattutto alle articolazioni per qualche presa ben riuscita dell’avversario) o per decisione dell’arbitro. La resa in assenza di queste condizioni è un disonore e una maniera scura per uscire dal circuito. Al momento i casi di esiti mortali sono rari ad alto livello, ma più frequenti nelle competizioni semi amatoriali, diffusissime un po’ ovunque ma soprattutto in Sudamerica, Giappone e negli USA.
Un’altra considerazione importante, fra le tante che questo fenomeno richiederebbe, riguarda le origini della disciplina. In realtà il combattimento a tecnica mista è antichissimo: nella Grecia classica si chiamava il Pancrazio ed era molto popolare. Dagli anni Venti del secolo scorso fu diffuso a livello ufficiale soprattutto in Brasile, dove si chiamava, significativamente, “valetudo” (tutto è permesso) e dove i match, soprattutto quelli che vedevano protagonisti i membri della sterminata famiglia Grace, riempivano di migliaia di persone i palazzetti. Jonathan Gottschall, un docente di letteratura inglese all’Università di Pittsburgh, ha voluto provare a entrare nelle gabbie ottagonali tipiche della MMA e sostenere un combattimento vero, dopo mesi di allenamento durissimo per un uomo di quarant’anni qual era. Secondo il suo pensiero il duello singolo fra maschi della specie è diffuso in tutto il regno animale e il nostro approccio, comprese le torve e prolungate occhiate, è mutuato da quello dei nostri antenati primati. È un libro molto interessante quello in cui Gottschall ha descritto la sua rude esperienza: Il Professore sul Ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli (Bollati Boringhieri 2015-330 pagg, € 6,49). Alla fine, però, il raffinato intellettuale finisce un po’ per mitizzare i valori (coraggio, appunto, resistenza al dolore) dei lottatori e non spiega in maniera convincente la vera questione: perché questo sport violento, molto più crudele della boxe, sta sempre più affermandosi nei nostri tempi, a livello televisivo e di numero di praticanti.
Antonio Franchini, editor di narrativa italiana alla Mondadori e da sempre praticante di arti marziali “ tradizionali “, quelle dotate di regole tanto fisse e intangibili, che sembrano i dogmi di una religione, sostiene: “Per una folla avida di emozioni violente, incontri del genere possono essere più semplici e appassionanti perché, rispetto a un classico match di pugilato, la tecnica, che pure c’è, non riesce a mascherare la brutalità”. Già, al fondo c’è una questione di mercato e di moda, di un prodotto da vendere. Le MMA sono una sintesi di varie discipline antiche e codificate, così come gli spettacoli delle arene romane mettevano a confronto gladiatori armati diversamente fra loro.
Il pubblico amava molto queste sintesi, queste contaminazioni, come diciamo oggi. Citando ancora Franchini “gli americani (i moderni romani) però sono stati i primi – grazie al loro talento nel rimettere sulla scena, con migliore illuminazione, il già esistente e nel farsi predatori da tutto il mondo di storie che poi a tutto il mondo rivendono confezionate meglio – a organizzare l’evento e a disegnare l’arena: uno spazio ottagonale circondato dalla versione tecnologica, in acciaio, di una palizzata primitiva. Una via di mezzo tra un ring, una gabbia per le fiere e il territorio sacro per combattimenti rituali di qualche civiltà antica, realmente esistita o del tutto immaginata da una fabbrica dei sogni cui il sacro ripugna ma che, pure, ne coltiva una certa nostalgia, soprattutto quando si rende conto che rispolverare usanze ancestrali può servire a individuare un pubblico e quindi un mercato” (le citazioni sono tratte dal bellissimo Gladiatori, Il Saggiatore, 2006, pagg 183, € 9,99).
Nelle Arene della MMA i contendenti entrano in scena, prima di salire nella gabbia, circonfusi da luci in stile Star Wars o simil discoteca, i loro tatuaggi sono elaboratissimi, le loro facce irrimediabilmente corrucciate e cattive: sono macchine per la lotta e, al contempo, personaggi dei fumetti, di libri e film fantasy, orchetti ed eroi mitologici. Rispondono a vecchie regole dello show business, i lottatori, ma sono anche ideologicamente consanguinei del personaggio di Gekko, in Wall Street di Oliver Stone, vivono in quel pezzo di mondo mentale in cui conta solo la vittoria, in cui il fallimento non è ammesso e deve essere punito, al massimo onorato con il riconoscimento del vincitore.
Gottschall ricorda giustamente un dibattito elettorale del 2012 fra Obama e Mitt Romney nel quale i candidati potevano muoversi, in uno spazio limitato, avvicinarsi l’un l’altro, a distanza di braccio, guardarsi fissi negli occhi, da vicino: una rissa virtuale, secondo regole televisive certe. D’altronde molte delle infinite serie proposte dalle tante piattaforme digitali propongono con costanza pestaggi di strada molto realistici. La crudezza è un tratto distintivo di questi nostri anni. Il primo, choccante evento dell’Ufc andò in scena nel 1993, Fight Club di Chuck Palahniuk arrivò in libreria tre anni dopo. Per tutti gli anni settanta e ottanta aveva furoreggiato il mito di Bruce Lee, che Dana White vede come un precursore delle MMA.
Un argomento complesso, come ho cercato di far vedere, impossibile da sottovalutare o da gestire con provvedimenti amministrativi. Già, come abbiamo visto, letterati di livello lo hanno analizzato. Prima o poi qualche libro o qualche buon film ( già la trasposizione di Fight Club con Brad Pitt è oramai un cult) ne canteranno l’epica fosca e abrasiva e lo immergeranno nel mito, come avvenne per la boxe.