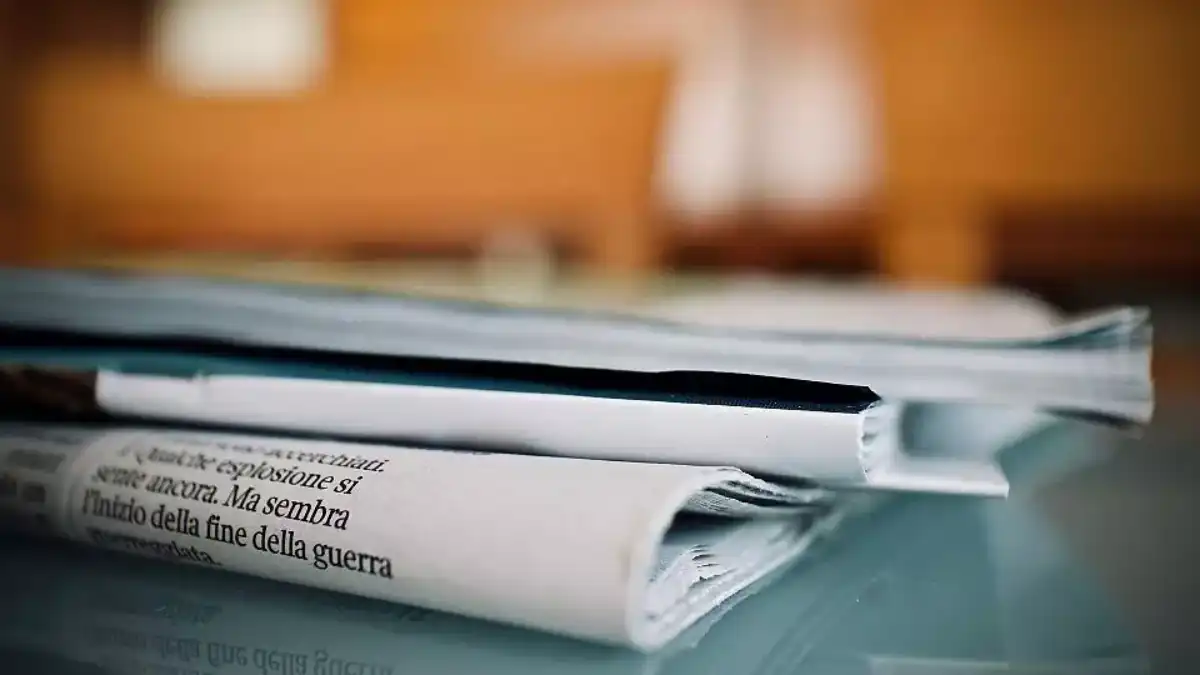di Manuela Ballo
È un libro che serviva al campo giornalistico, quello di Carlo Sorrentino uscito da poco tempo nelle librerie (Il giornalismo ha un futuro. Perché sta cambiando, come va ripensato, Il Mulino, 17 euro). Serviva perché dopo anni e anni di discussioni sulla perduta titolarità esclusiva da parte dei giornalisti della notizia, il volume indaga sia i profondi cambiamenti avvenuti, sia le prospettive in questa fase di sovraccarico informativo. Dei contenuti del libro abbiamo rivolto alcune domande allo stesso autore che insegna Sociologia dei processi culturali e Giornalismo e sfera pubblica all’ Università di Firenze, oltre a dirigere la rivista “Problemi dell’ informazione”.
Dopo tante elucubrazioni sulla fine del giornalismo sarebbe più opportuno parlare – come afferma nel suo libro – di una sua trasformazione genetica. Come può essere reinventato data questa trasformazione?
Non possiamo rinunciare a istituzioni che abbiano la funzione di mediarci le informazioni; proprio perché in giro ce ne sono tantissime, postate da chiunque e quindi non controllate. La mia posizione, più che essere ottimistica, cerca di rilevare questo dato di fatto. Senza mediazione giornalistica non ci può essere condivisione di quanto accade intorno a noi e quindi non può esserci coesione sociale! Tuttavia, l’ecosistema informativo è totalmente cambiato negli ultimi decenni con l’avvento del digitale, che ha stravolto le modalità con cui noi tutti fruiamo le informazioni, nonché le modalità di distribuzione delle notizie; ne consegue che deve essere ripensata profondamente anche la produzione delle notizie.
Al giornalismo non chiediamo soltanto di dirci cosa è successo e a causa di chi; anche perché queste informazioni le possiamo reperire attraverso varie fonti. Piuttosto chiediamo di chiarirci il perché. Delle 5 famose w, il why diventa la principale. Dunque, al giornalismo chiediamo di inquadrarci le notizie attraverso delle solide contestualizzazioni e di interpretarcele. Un lavoro più approfondito che richiede solide competenze e un’adeguata formazione.
La distinzione tra “essere giornalista” e “fare giornalismo”: qual è la differenza sostanziale tra queste due funzioni?
Se nostro figlio cade per strada e si sbuccia un ginocchio, noi lo disinfettiamo e gli mettiamo un cerotto. Ma non per questo siamo degli infermieri. Analogamente, può capitare di postare una nostra foto relativa a un evento importante a cui abbiamo assistito, così come di dare una notizia perché ne siamo stati testimoni oculari. Ora attraverso i social è possibile. Il famosissimo video della morte per soffocamento di George Floyd fu realizzato da una ragazza di 17 anni che ebbe la prontezza di capire cosa stava avvenendo davanti ai suoi occhi. Ma di certo quella ragazza non è una giornalista, anche se realizzò un “atto giornalistico” di grandissima rilevanza.
Lei sostiene che, nonostante tutto, il giornalismo continui a costituire una delle principali forme di conoscenza della società. Questo è valido anche dopo il crollo della credibilità e dell’immagine di questa istituzione?
Il crollo di credibilità è un enorme problema. Ma non soltanto per i giornalisti o per gli editori. Ma per tutti noi. Per le società in cui viviamo. Noi abbiamo bisogno di sapere che quanto ci viene raccontato corrisponde alla realtà. Non parliamo di verità, perché è un termine scivoloso, più adatto a dibattiti filosofici che per parlare di giornalismo.
Purtroppo, la caduta di fiducia ha varie cause. Il sistema giornalistico negli ultimi anni è stato chiamato a produrre di più, per una varietà di canali, ma con meno risorse, poiché la maggior parte degli introiti pubblicitari in tutto il mondo finiscono nelle mani di poche piattaforme digitali e noi pubblico, avendo tante informazioni gratuite, facciamo difficoltà a riconoscere che per l’informazione professionale bisogna pagare. Ciò ha determinato una minore cura nel lavoro giornalistico; nonché la predilezione per notizie che possano più facilmente attirare l’attenzione. Da qui le notizie gridate, la logica contrappositiva, per cui tutto diventa o bianco o nero, la radicalizzazione delle posizioni.
Inoltre, la facilità con cui – come dicevo prima – chiunque può postare notizie incontrollate e l’analoga facilità con cui le riceviamo senza interrogarci della loro verifica e completezza ha prodotto una diffidenza e uno scetticismo diffuso. Per questo motivo, io credo che così come parliamo di responsabilità per il mondo dell’informazione dovremmo parlare anche di responsabilità di ciascuno di noi nel “perdere un po’ più di tempo” per assicurarci che quanto leggiamo, vediamo o ascoltiamo provenga da una fonte attendibile.
Nelle proposte che lei avanza, oltre all’ indispensabile cambiamento delle routines produttive, mette anche il sistema di selezione e classificazione delle notizie. In che modo tutto questo avviene?
Per far riavvicinare le persone all’informazione serve maggiore trasparenza. Far capire al pubblico quali sono i percorsi attraverso cui i giornalisti selezionano, verificano, gerarchizzano e presentano le notizie. Quando andiamo dal medico dobbiamo firmare il consenso informato, cioè il medico deve dirci perché ci fa determinati interventi, come ce li farà e che rischi corriamo. Analogamente, il giornalismo dovrebbe essere più chiaro nel coinvolgere il pubblico in quello che fa e nello spiegare come si arriva a prediligere certe notizie ad altre e perché sono più importanti di altre.
Perché ritiene ancora valida la definizione di “campo giornalistico”? E quali possono essere i percorsi per ristabilire un nuovo patto tra il pubblico dei lettori e il giornalismo?
Il concetto di campo giornalistico è ancora valido proprio perché con questo concetto Pierre Bourdieu voleva sottolineare la pluralità di attori che incide, in diverso modo e a diverso titolo, nella produzione informativa. Mai come oggi questo campo è affollato ed è importante studiare e riflettere sul giornalismo proprio per comprendere meglio chi fa che cosa e come in questo campo.
Io parlo di un nuovo patto di fiducia che si basi su una migliore capacità degli editori e dei giornalisti di pensare progetti editoriali maggiormente inclusivi delle esigenze e delle volontà del pubblico. Per questo parlo di progetti identitari, che facciano sentire più partecipi i pubblici. Ma allo stesso tempo, come ricordavo, è importante che il pubblico riscopra il valore del bene notizia, che è un bene pubblico, come l’acqua che ci serve per bere e lavarci, oppure la qualità dell’aria che respiriamo. Riscoprire tale valore vuol dire anche essere disposto a pagare qualcosa per avere delle informazioni affidabili e di spendere un po’ di tempo in più per verificare se le informazioni che ci arrivano sullo schermo dello smartphone sono credibili o meno.